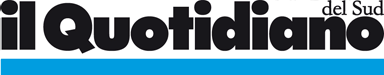Uno degli scatti inseriti nel libro “Storie di straordinaria flânerie”, del sociologo, scrittore e divulgatore scientifico Cleto Corposanto
7 minuti per la letturaPRATICA l’arte di andare a zonzo. Senza fretta, osservando il mondo. In valigia? La curiosità di conoscere luoghi e persone e uno spirito guida a cui si ispira: il flâneur, alla maniera di Baudeleire. Il flâneur (in italiano colui che bighellona/passeggia), “uno che porta al guinzaglio delle tartarughe lungo le vie di Parigi”, lo definiva l’autore dei Fiori del Male che nel 1850 coniò il termine riferendosi ai parigini dell’epoca. Da allora la flânerie (vagare) è diventata una filosofia di vita oltre che un modo di viaggiare o semplicemente di camminare nei luoghi più familiari guardandoli con un occhio diverso. Andamento lento. Senza fronzoli, senza mete, senza orologio, senza lacci. La posta in palio? Cercare, trovare e vivere lo stupore.
Parte da qui “Storie di straordinaria flânerie” l’ultimo lavoro del sociologo, scrittore e divulgatore scientifico Cleto Corposanto. In libreria per l’editore Rubbettino, avrà la sua prima presentazione il prossimo 18 luglio al campus universitario di Germaneto. In Calabria, a Catanzaro. Il volume è il terzo lavoro del sociologo dedicato al tema del viaggio. Centonovantadue pagine corredate da fotografie scattate dall’autore e una costruzione narrativa del tutto particolare: ai capitoli dedicati ai diversi luoghi visitati si alternano gli Intermezzi.
Si tratta di riflessioni socio-filosofiche, stile Zibaldone leopardiano: «Un modo diverso di parlare del significato sociale del viaggio a tutto tondo, nelle sue mille possibili sfumature dense di significati e significanti di volta in volta esplicitati. Fermo restando che, nel mio approccio al viaggio, è la flânerie a rappresentare la modalità che più mi aggrada, una modalità che si può vivere con la forza della contemplazione, con una determinazione verso l’inattività che mi sembra sempre di più l’unica risposta possibile a una richiesta di performance e di velocità che pervadono tutte le nostre vite, anche non lavorative. L’inattività e la contemplazione, il girovagare senza scopo, se non quello di contemplare, inattivamente, mi sembrano le uniche risposte possibili alla performance», scrive il sociologo.

«Se rappresentassimo le possibili modalità di viaggio lungo un ipotetico asse, la flânerie starebbe su un estremo: su quello opposto, probabilmente, troveremmo le crociere e i viaggi mordi e fuggi in Europa degli asiatici dell’estremo Oriente: sette giorni, cinque nazioni, mille palazzi e un milione di foto; la velocità – facilitata – che rende il viaggio performante, contro la lentezza contemplativa non finalizzata. Collezionismo di posti e luoghi buoni da vivere un istante e superare l’attimo successivo contro lentezza inattiva rigenerante non finalizzata. La flânerie non porta all’inazione: è essa stessa inazione, estraniamento totale dai fini, pur vivendo intensamente ogni attimo, ogni luogo, ogni incontro. Finta curiosità instagrammabile da un lato, voglia di rigenerazione solitaria dall’altro. Aveva ragione un grande viaggiatore come Ryszard Kapuscinki quando, raccontando il proprio errare rievocando la lettura di Erodoto, commenta che l’uomo comune, oggi, non è particolarmente curioso, e fa di tutto per fare le cose con il minimo sforzo. Ma conoscere il mondo è un’operazione che costa fatica, richiede un grande sforzo che rischia di prosciugare tutte le energie disponibili». Camminare per le strade del mondo, ispirarsi alla flânerie e scrivere diari di viaggio col cuore e lo sguardo da flâneur o da flâneuse consente anche di «riappropriarsi del racconto, della narrazione, della parola che incanta e seduce, che si dipana e avvolge catturando l’attenzione, fermando il tempo. Perché è proprio il raccontare storie quello che ci differenzia dalle altre specie viventi, rendendoci umani sapiens e non consumer: la loro condivisione rafforza il progetto di essere comunità, l’unica espressione di vita possibile per essere realmente donne e uomini del mondo».
Tra le pagine del libro prende forma un mappamondo colorato con i racconti di viaggi che si intersecano alle immagini immortalate senza pose e artifici. Muscat, Bangkok-Pattaya, Phnom Penh, Giakarta, Berlino, Florianópolis, Vietnam, Brunei: luoghi e storie. Incontri e taccuini dei ricordi. Viaggi e riflessioni come nell’Intermezzo 13 dedicato al filosofo e sociologo francese Edgar Morin e al silenzio: «I silenzi non sono sempre uguali, tutt’altro. Ci sono silenzi che sottintendono esclusione; e ci sono invece silenzi che hanno il grande valore dell’ascolto, della partecipazione, dell’esserci, che sono solo una risposta alla rumorosa, urlata, sguaiata modalità di relazionarsi di questa società […]E poi c’è il silenzio del viaggiatore solitario, che sceglie la condizione da “single” anche perché, in silenzio, potrà godere meglio di tutte le cose fantastiche che un viaggio lento, nella società della velocità e della prestazione, è in grado di regalare. Senza correre, senza milioni di foto inutili, perché quello che si vede fotografando non è la stessa cosa di ciò che guardiamo con gli occhi, senza parole inutili che tolgono spazio al pensiero».
Un approccio questo che, come si intuisce da un altro Intermezzo questa volta dedicato al noto antropologo britannico Tim Ingold, invita a fare una distinzione fra le trame e le linee delle nostre vite. «Le linee rappresentano le convenzioni e le rappresentazione astratte – ricorda Corposanto – mentre le trame si riferiscono alle pratiche materiali e alle esperienze in continua evoluzione». È qui che si ritrova il legame con le esperienze che si possono accumulare durante un viaggio pensato, organizzato e vissuto con la forza dell’inazione. Con la ricerca del tempo perduto e delle relazioni ritrovate. Ed è questa la ragione per la quale l’autore, allineandosi con il pensiero unico e in qualche modo rivoluzionario di Ingold, invita ad enfatizzare «l’importanza di spostare l’attenzione dalle linee astratte alle trame delle pratiche e delle esperienze reali».
I reportage di viaggio, i racconti degli incontri e le riflessioni socio-filosofiche fanno il paio con le storie e le leggende del mondo. Una narrazione che segna un’inversione di tendenza rispetto all’arte affabulatoria di scrivere o raccontare catturando l’attenzione e l’interesse del pubblico, così di moda nella società consumistica. «La flânerie, viaggiare da flâneur – scrive il sociologo – ci mette in contatto con miti e leggende, in un percorso di conoscenza condiviso con luoghi e persone che incontriamo. In una società che mercifica la nostra quotidianità, siamo passati da raccontare storie a seguire storytelling: con il risultato di accentuare la forza che spinge all’individualismo indebolendo quella che crea comunità».
Altro Intermezzo. Al numero 16 troviamo quello dedicato agli oggetti e alle memorie: «Gli oggetti sono importanti, sono baluardi della memoria, servono a rivivere emozioni che altrimenti con il tempo rischiano di affievolirsi, sono indicatori di vita vissuta». Si viaggia con i mezzi di trasporto è vero ma ci si porta dietro quel che si è. Secondo il sociologo, si viaggia sopratutto col corpo. Intermezzo 2: «Un viaggio pensato, meditato, sognato, idealizzato, e alla fine realizzato e vissuto intensamente, infatti, ha a che fare con il nostro corpo e con i nostri sensi, in una riproposizione di sensazioni elementari che spesso vengono travolte, rimescolate, finanche esasperate. Il paradosso iniziale è che un viaggio nasce sostanzialmente da fermo, leggendo un libro o sfogliando un atlante, guardando un filmato online o mettendo in ordine oggetti simulacro, provenienti da precedenti spostamenti. È lì che un pensiero prende forma, comincia a viaggiare, inizialmente in maniera alquanto confusa e poi, via via invece sempre più netta».
Un’altra riflessione Corposanto la riserva al tema dei confini, che sono geografici, politici ma spesso fanno anche da perimetro a molti nostri pensieri. Confini che sono sempre culturalmente determinati, confini la cui esaltazione molto spesso porta a coltivare fenomeni di etnocentrismo da un lato e supremazia verso il diverso dall’altro. Per questa ragione, probabilmente, l’autore confessa di essere affascinato dai posti di confine, che «sembrano posti un po’ magici, dove le cose si affievoliscono e si fondono, luoghi nei quali le dicotomie non esistono». «L’umanità ha sempre viaggiato per millenni lungo le vie del mondo – osserva ancora il professore – e ciascuno di noi è il risultato biologico dei viaggi di milioni di persone, con ogni mezzo, lungo strade che non avevano confini. I confini li abbiamo creati dopo: e non sono certo che siano stati una delle invenzioni più brillanti dell’umanità».
E alla fine tornando a casa i punti di domanda che hanno accompagnato le partenze e i viaggi restano insieme alle parole di Milan Kundera tratta da La lentezza (1995) che chiudono il volume e parlano di flânerie: «Perché è scomparso il piacere della lentezza? Dove mai sono finiti i perdigiorno di un tempo? Dove sono quegli eroi sfaccendati delle canzoni popolari, quei vagabondi che vanno a zonzo da un mulino all’altro e dormono sotto le stelle? Sono scomparsi insieme ai sentieri fra i campi, insieme ai prati e alle radure, insieme alla natura?».
La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.
Contiamo su di voi per preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell’Italia riunita.
ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI.
TI potrebbe interessare
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA