Vito Teti
9 minuti per la letturaCENSITA come neologismo da Treccani nel 2017, la parola ‘restanza‘ ha vissuto nell’anno che ci siamo lasciati alla spalle la stagione della sua riscoperta. Una rapida ricerca in rete ci restituisce un’inchiesta giornalistica (Corsera), un documentario (firmato dalla regista Alessandra Coppola) e una ricerca sociale (promossa dall’associazione ‘Riabitare l’Italia’), che si aggiungono a una lunga lista di occasioni (convegni, articoli, interventi) in cui è stato affrontato il tema del restare o tornare nei luoghi d’origine, spinti (anche) dalla pandemia e aiutati dallo smartworking. Più che un tema: un’intenzione che si fa sempre più diffusa e che in tanti casi si concretizza in una scelta.
Una recente indagine condotta dal dipartimento di Scienze politiche e sociali Unical – raccontata da Domenico Cersosimo e Sabina Licursi nelle scorse settimane sul Quotidiano – ha rivelato, ad esempio, che il 64% degli under 39 residenti nelle aree interne della Calabria non vuole abbandonare i propri paesi. L’origine della parola restanza – o meglio il suo utilizzo come categoria antropologica per definire la condizione di chi sceglie di restare nei luoghi in cui è nato e cresciuto – va però retrodatata, rispetto a Treccani, di sei anni. La utilizza nel 2011 l’antropologo Vito Teti nel suo “Pietre di pane. Un’antropologia del restare”.
«Il fatto che io l’abbia introdotta in un saggio che raccoglie racconti di viaggi e migrazioni può probabilmente suonare singolare. Il fatto è che io ho sempre legato la restanza a situazioni di dinamismo, di mobilità. Non è una condizione di attesa, esiste sempre in relazione al movimento degli altri o al proprio. Perché è possibile spostarsi anche senza allontanarsi dal posto in cui si è nati. Restare è anche mettere in discussione i propri luoghi, conoscerli in modo nuovo, rischiare anche di sentirsi spaesati».
Teti, già docente di Antropologia Culturale all’Università della Calabria, è tornato più volte sul tema nel corso degli anni. Le sue riflessioni più recenti, condotte al tempo della pandemia, sono contenute ora in un nuovo saggio – dal titolo, appunto, ‘La restanza’ – che arriva oggi in libreria per Einaudi, nella collana Vele.
La restanza esce a undici anni da “Pietre di pane. Un’antropologia del restare”. In mezzo il Covid, ma anche una serie di emergenze nuove che lei cita nel testo come il cambiamento climatico. Qual è la differenza tra i due testi? Com’è cambiata la sua riflessione in questi anni?
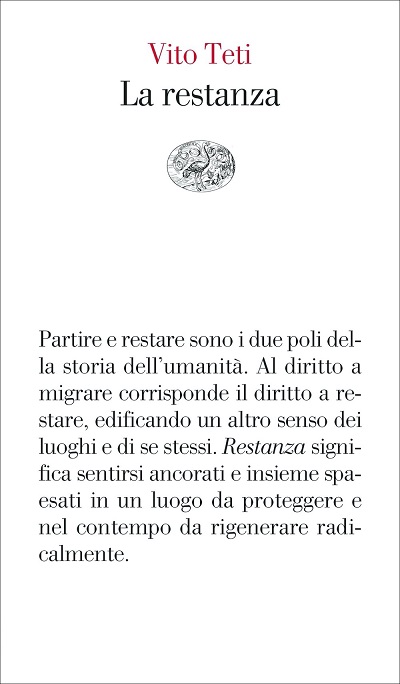
«Abbiamo assistito a un fenomeno interessante. La teorizzazione della restanza da parte di movimenti, associazioni, giovani. I ragazzi prima volevano partire, oggi preferiscono restare. Lo dicono i dati, ma anche io da docente l’ho verificato tra i miei studenti. Il mito dell’altrove, la fuga a ogni costo sono stati cancellati. C’è un movimento pre-politico, potremmo dire, basato su un forte senso di responsabilità verso i propri luoghi. Il Covid ha avuto, nei tempi più recenti, un suo ruolo. Ci ha mostrato un modo nuovo di restare – dovuto alla costrizione più che alla scelta – e ha fatto emergere la voglia di tornare di tante persone. Devo dire che questa aspirazione non ha incontrato una risposta adeguata da parte della politica. Infine l’altra emergenze dei nostri tempi, la crisi climatica: ha spinto ad avere una maggiore cura dei luoghi. Ha alimentato una restanza, intesa come forma di resistenza rispetto alle catastrofi naturali o provocate dall’uomo. Devo dire, però, che quando si parla di restanza, si continua a raccontare il fenomeno come se fosse esclusivo delle periferie, dei paesi. Per me è un modo nuovo di abitare, che coinvolge anche chi vive in città».
Da una recente ricerca Unical è emerso che il 64 per cento dei giovani calabresi, residenti nelle aree interne, vuole restare. In che modo i restanti di oggi sono diversi da quelli di ieri?
«Sono più acculturati, hanno una consapevolezza diversa: restano per creare condizioni nuove di abitare nel luogo in cui sono nati. Non bisogna, però, abbandonarsi al mito ruralista, al mito del borgo. Restare è difficile e non ci sono, nonostante gli annunci, politiche reali in grado di sostenere chi fa questa scelta. Manca il lavoro, non ci sono infrastrutture, la criminalità è una presenza ancora marcata. La politica non trattiene i giovani, non ostacola quei fenomeni che li respingono, li allontanano. Né si favorisce la crescita demografica. I paesi non muoiono da soli, ma perché ai giovani che partono si accompagna anche il calo delle nascite. Servono aiuti a sostegno delle famiglie, perché chi vuole un secondo figlio sia messo in condizione di mantenerlo. Senza dimenticare la fragilità del nostro territorio, esposto al rischio frane, incendi, terremoti. Perché non si riesce a metterlo in sicurezza? Non si capisce».
C’è chi parte, c’è chi resta e c’è chi torna. È un effetto anche questo della pandemia, lo chiamiamo southworking. Sono anche loro i nuovi restanti.
«Tornano alla ricerca di una migliore qualità di vita, in molti casi. E qui dobbiamo fare molta attenzione: se li deludiamo andranno via di nuovo, per non tornare più. Sarebbe una perdita enorme: alimenterebbe l’idea che vivere qui sia impossibile e che per la Calabria non ci sia nulla da fare. Servono incentivi reali, politiche di sostegno, servizi di qualità, una sanità migliore. Altrimenti non andremo oltre gli slogan».
Non è una condizione statica quella di chi resta, lo diceva all’inizio. Nel testo lo spiega con immagini molto belle. “La restanza è il sentimento di chi àncora il suo corpo a un luogo e fa diaspora con la mente”. È il viaggio da fermo, è l’attesa attiva. Restare come speculare a viaggiare, e non (o non solo) in antitesi. In che senso?
«Chi resta è come se dovesse viaggiare quotidianamente. Deve inventare un senso giorno per giorno, misurarsi con quello che non c’è o non c’è più. Non è una questione di nostalgia, è che con il passare del tempo i luoghi cambiano, si svuotano. Si fa i conti con qualcosa che muta, mentre si resta ‘fermi’. Restare significa anche sentirsi disadattati, non pacificati. Chi resta si domanda ‘chi me lo ha fatto fare?’, così come forse fa anche chi è partito. Noi dovremmo saldare queste due inquietudini per creare un nuovo senso dell’abitare. Ecco quindi che restare e viaggiare diventano due immagini dello stesso senso di mobilità».
Muoversi come camminare. Lei dedica un capitolo del libro al cammino, possibile punto di incontro tra restare e migrare. Negli anni in cui si afferma il senso della restanza e la voglia di ritornare, abbiamo assistito anche a una riscoperta dei cammini. Ne nascono di nuovi, anche in Calabria, come il cammino basiliano.
«Sì, è vero. Camminare è una mediazione tra il bisogno di viaggiare e quello di restare. È partire alle 8 di mattina per tornare, alle 8 di sera, nel punto da cui si è partiti. Cammini, rifletti, osservi, alla fine rimani perché dal tuo luogo non ti sei allontanato. I cammini circoscritti ti consentono di spaesarti, di spostare corpo e mente e ritrovarti. Ti fanno stare in un modo diverso nel posto in cui vivi, sono per questo salvifici e terapeutici. La Calabria ha una tradizione antica, è stata terra di transumanza e oggi il cammino è un suo grande bene immateriale, che, come il suo paesaggio, potrebbe anche alimentare la restanza. Il problema è che noi tendiamo molto alla retorica, poco alla concretezza quando si tratta di tutelare i nostri beni. È in questo senso anche che parlo nel testo di etica del restare: se sei consapevole delle risorse che hai, devi avere la responsabilità e la coerenza di valorizzarle. Devi trasformare in atti concreti quello che annunci».
La restanza è una categoria universale?
«Avrei difficoltà a definirla una categoria filosofica. È piuttosto una categoria antropologica. È difficile dire se l’uomo sia naturalmente nomade o stanziale: pensi ai grandi spostamenti della storia, influenzati da eventi come crisi climatiche, terremoti, catastrofi. Restare (o partire), in questo senso, è una scelta culturale, condizionata da quello che noi chiamiamo natura».
Restare e tornare sono temi molto presenti nei romanzi italiani degli ultimi anni. Nel libro lei cita Marco Balzano e Donatella Di Pietrantonio. Testimoniano una riflessione presente e diffusa, anche prima del Covid.
«Sì. Credo abbia influito molto la consapevolezza dello spopolamento, dell’erosione delle nostre aree interne. Si è andati, e si sta andando, alla ricerca di un nuovo modo di abitare nelle periferie, nei luoghi marginali. Penso sia anche una presa d’atto del fallimento della globalizzazione. Lo sta dimostrando anche la guerra in atto: il locale può coincidere con noto, sicurezza, appartenenza. Il rischio da evitare, però, è di cadere nel localismo. Ecco, locale non significa rinchiudersi, ma sfuggire all’omologazione. Serve quindi un locale capace di incontrare i frutti migliori del globale, ovvero lo scambio, il confronto, il viaggio».

Il testo è anche autobiografico. Racconta di lei, che è un restante: vive nel luogo in cui è nato, San Nicola da Crissa, nella casa in cui è nato. E tuttavia è anche sempre in viaggio, perché fa l’antropologo. Lei è, per citare sua madre, uno che non ha ricetto. Quindi com’è la sua restanza?
«Per usare ancora le parole di mia madre, continuo a non prendere ricetto. Si può pensare che chi abita nel luogo in cui è nato sia felice, pacificato. Come dicevamo, però, restare è inquietudine. È sentirsi estraneo in un luogo che dovrebbe appartenerti. Dopo aver assistito al grande esodo mi sono reso conto che diventavo un testimone e ho capito che la mia biografia incontrava il mio mestiere di antropologo, le mie scelte affettive e anche quelle politiche. Perché nel tuo collocarti devi prendere posizione».
Cosa le provoca sofferenza nel suo restare?
«Vedere i giovani partire. Lo vivo con un profondo senso di ingiustizia: ancora oggi non sono state create le condizioni per cui partire possa rappresentare una scelta e non un obbligo. Io ho atteso per dieci anni il ritorno di mio padre, che era emigrato in Canada poco prima della mia nascita. Grazie al suo sacrificio ho potuto studiare, ma 10 anni della mia vita sono stati l’attesa del padre. Oggi assisto alla partenza dei miei figli. Mi sento un incidente tra due generazioni».
Quando la restanza può essere felice?
«Quando hai la consapevolezza di essere in un posto che devi abitare con cura e attenzione. Un posto che cerchi di migliorare e che non consideri bello solo perché è tuo. Dobbiamo avere la responsabilità dei luoghi che abitiamo. Responsabilità di stare nel mondo, di affermare una presenza. Quando penso a luoghi che si ripopolano perché i giovani tornano a fare smartworking, io immagino luoghi abitati da persone che – dopo aver lavorato da remoto durante il giorno – poi si incontrino, si conoscano. Purtroppo i luoghi di incontro sociale – le biblioteche, le associazioni, i centri – li abbiamo chiusi. Ecco, dovremmo ripartire anche da qui».
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA



